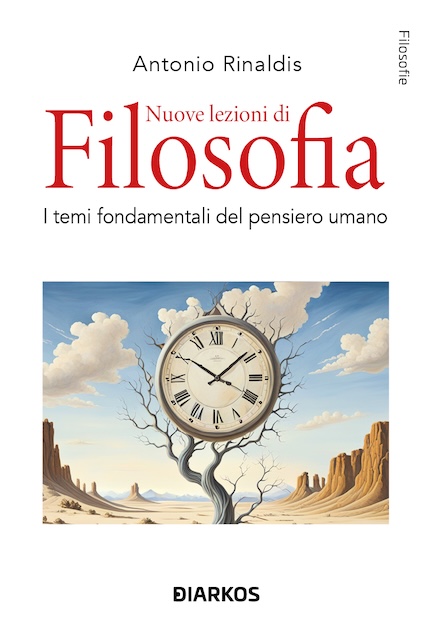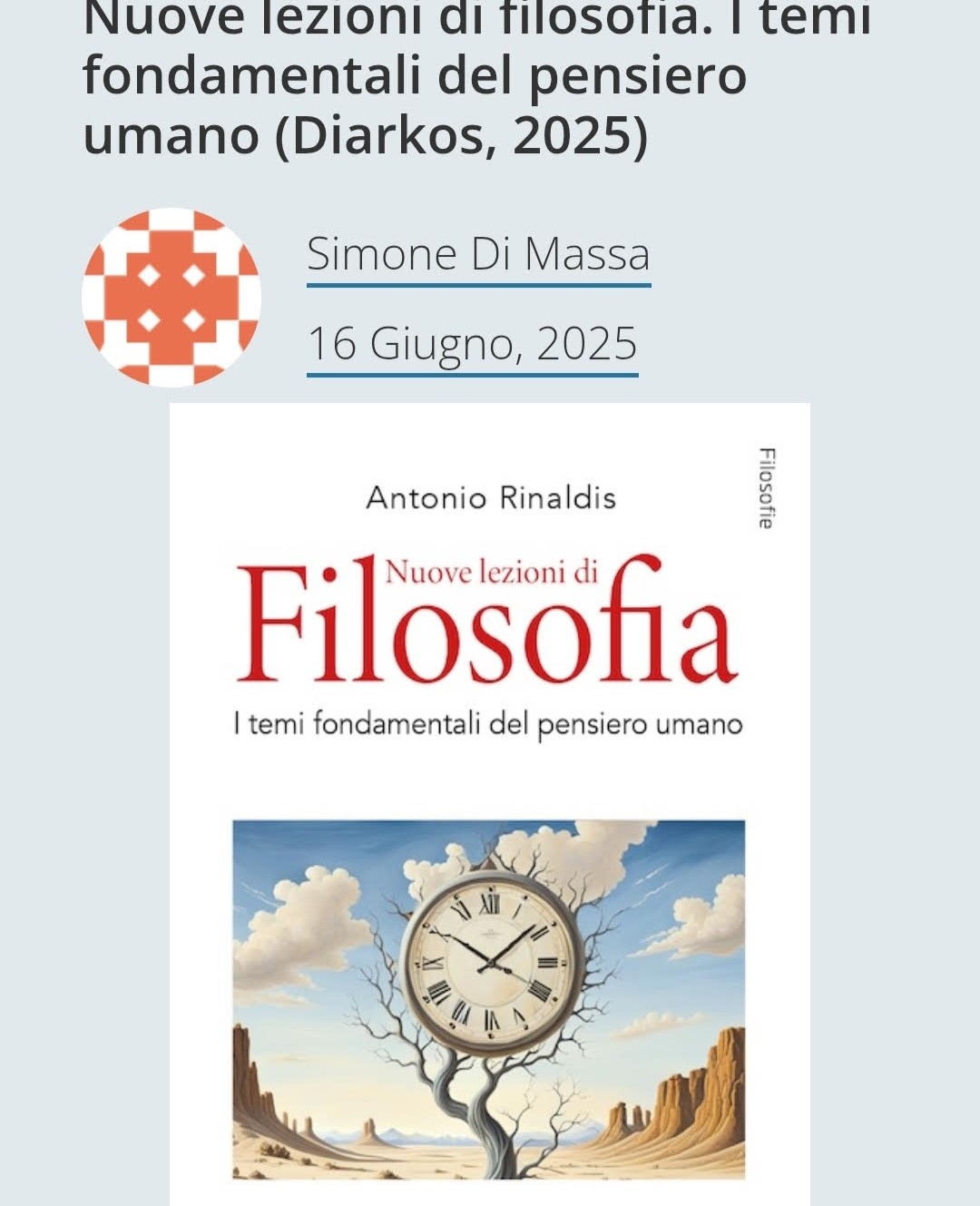
[Recensione] Antonio Rinaldis – Nuove lezioni di filosofia. I temi fondamentali del pensiero umano - Scuola filosofica
17 Giugno 2025
Nel tentativo di proporre voci e parole nuove nell’ambito del dibattito filosofico, plurisecolarmente e polifonicamente articolato e sviluppato, è talvolta necessario sovvertire l’impostazione manualistica che passa in rassegna, spesso cronologica, i pensatori, esaminando i loro lasciti e le loro ideologie, e proporre invece una disquisizione che parta dai grandi temi che interessano l’animo umano, volente o nolente, per poi addentrarsi nelle singolarità dei filosofi che ne hanno dibattuto.
Nel febbraio 2025 è uscito per la casa editrice Diarkos il volume Nuove lezioni di filosofia. I temi fondamentali del pensiero umano, a cura di Antonio Rinaldis: l’opera si inscrive nella produzione del prof. Rinaldis, che vede affiancati volumi filosofici (cfr. Rinaldis 2013; 2019) e volumi di interesse politico e attualistico (cfr. Rinaldis 2016). Il volume di recente pubblicazione, che conta 227 pagine, si articola in quattro capitoli, che fanno seguito a una breve Introduzione prefatoria (pp. 5-10), e che precedono una altrettanto breve Conclusione (pp. 223-2279).
L’Introduzione indirizza chiaramente gli scopi del volume: «Questo volume tratta di incontri e di ospiti inattesi, scomodi, di presenze che rimettono in gioco equilibri consolidati, sbriciolando certezze che parevano incrollabili» (Rinaldis 2025: 7-8); vale a dire, il volume non intende presentare una storia delle diverse ideologie filosofiche compendiandole in una rassegna di nomi e correnti di pensiero, quanto più di indagare le radicate convinzioni dell’animo umano, ponendo in risalto gli interrogativi e sciogliendoli, anche a costo di far crollare consolidate certezze. Tutto questo si avvale di un percorso lineare cronologicamente, ossia in progressione temporale, ma che spazia tra luoghi ben disparati, nomi e correnti di pensiero.
Merito dell’Introduzione è anche quella di porre da subito in risalto il carattere di spiccata multidisciplinarietà del volume: ogni ragionamento filosofico, come appare ben chiaro alla lettura, non si radica nella sola disciplina detta filosofia, che è di per sé, così a dirsi, un concetto astratto e scivoloso, ma fa ampio e sofisticato uso, tra i vari subsidia umanistici, ad esempio della letteratura. La menzione dapprima del celebre e meraviglioso Canto XXVII, Amore e Morte, di Giacomo Leopardi, e subito dopo dell’altrettanto sublime Ode a un’urna greca del poeta romantico John Keats, indirizzano chiaramente l’uso della letteratura come strumento di indagine.
Il primo capitolo ha nome Amor che move il sole e l’altre stelle (pp. 11-64): la menzione al proverbiale endecasillabo dantesco (Pd. XXXIII, 145) che chiude la Comedìa, ha qui invece il compito di introdurre una disamina della questione fulcro degli interrogativi filosofici umani, l’amore. L’analisi parte dalla mitologia greca, passando per i pensatori antichi, fino ai filosofi moderni e contemporanei: il primo filosofo menzionato è Empedocle, mentre chiude la schiera Roland Barthes. L’amore è indagato anche da un punto di vista maggiormente radicato nella società, spaziando dalla visione religiosa che ne offre il Cristianesimo, e arrivando alla commistione di politica e filosofia che è nel Manifesto del Partito Comunista di Karl Marx.
Seguono i capitoli La malinconia della Morte (pp. 65-111); La Bellezza tra natura e arte (pp. 113-168); Per una storia della Verità (pp. 169-221). Precisa Rinaldis che «l’ordine dei capitoli con cui è diviso il libro non è casuale. Amore e Morte da un lato, Bellezza e Verità da un altro, appaiono opposti, ma in realtà sono complementari, come le due metà di un intero» (Rinaldis 2025: 9). Si aggiunge che la scelta tipografica nel marcare con lettere maiuscole Amore, Morte, Bellezza e Verità è un sapiente modo di racchiudere quattro cardini della vita umana, che dunque necessitano un’elevazione, una personificazione, per essere trattati ed esaminati a fondo. È da questi quattro cardini personificati che si discende poi nelle ideologie, nelle visioni, nelle religioni e nelle politiche che costituiscono la società.
Sono proprio questi quattro cardini a chiudere il volume nella Conclusione, ove Rinaldis sintetizza quanto si è appurato su ognuno di essi: «Cosa sappiamo dell’Amore? Se non ce lo chiediamo lo sappiamo, se ce lo chiediamo non ne sappiamo niente, rispose Agostino alla domanda sul Tempo. Con la Morte discutiamo, con la speranza di rimandare l’appuntamento fatale […]. Dalla Bellezza siamo attratti e la ricerchiamo in tutte le sue forme, ma non sapremmo spiegare il motivo di una tale, potente fascinazione, dal momento che essa si manifesta in forme così differenti da risultare indefinibile. La Verità ci appare come una meta lontana e irraggiungibile, anche se nessuno vorrebbe trascorrere la propria esistenza nella menzogna e nell’orrore» (ivi, pp. 226-227).
Il volume ha così il grande merito di sviscerare queste così grandi tematiche dell’animo umano, e di farlo con acribia, con pluralità delle specole da cui si guardano le questioni, con pazienza e con passione. Al contempo, il volume ha come ultimo grande punto di forza quello di tracciare le proprie conclusioni rimarcando il carattere sfuggevole e talvolta oscuro dei cardini su cui si regge: «Per questi motivi la filosofia è perenne» (ibidem).
Link all'articolo: https://www.scuolafilosofica.com/12638/recensione-rinaldis-nuove-lezioni-di-filosofia-diarkos-2025