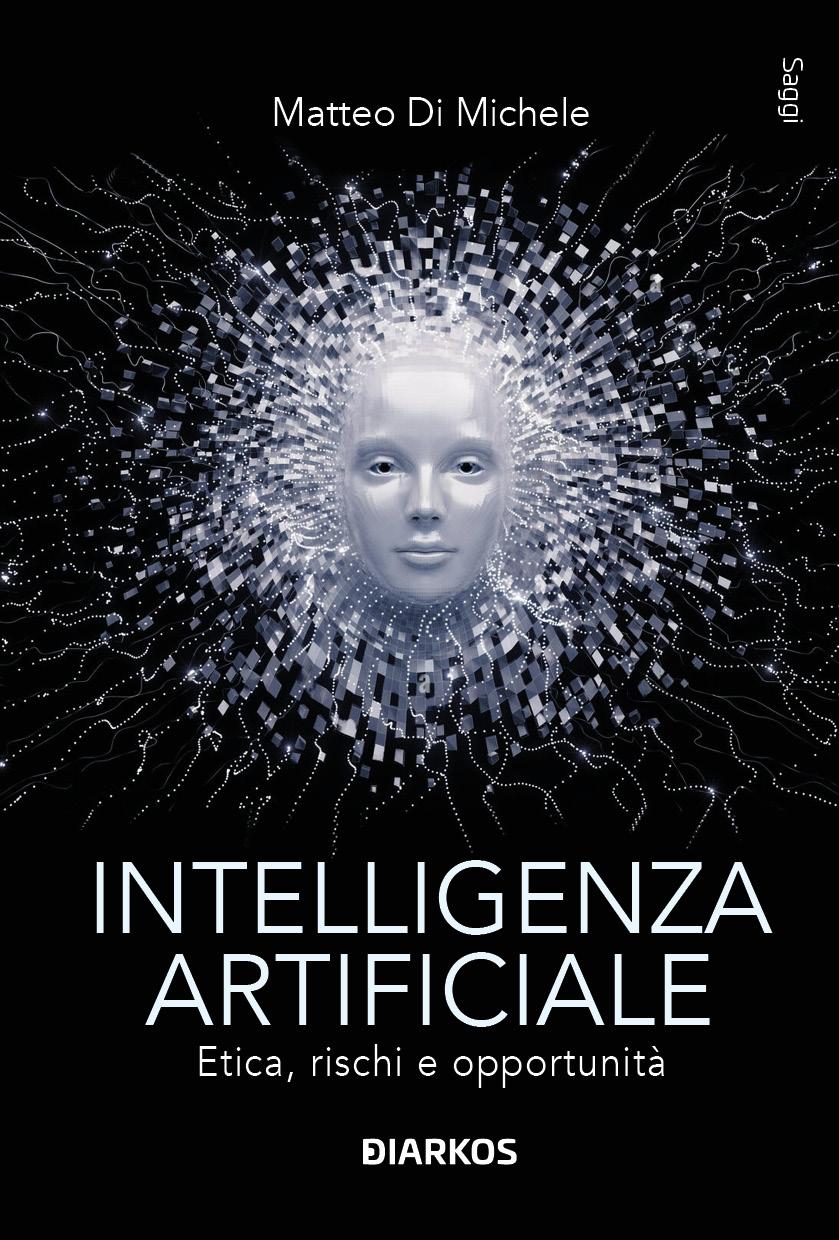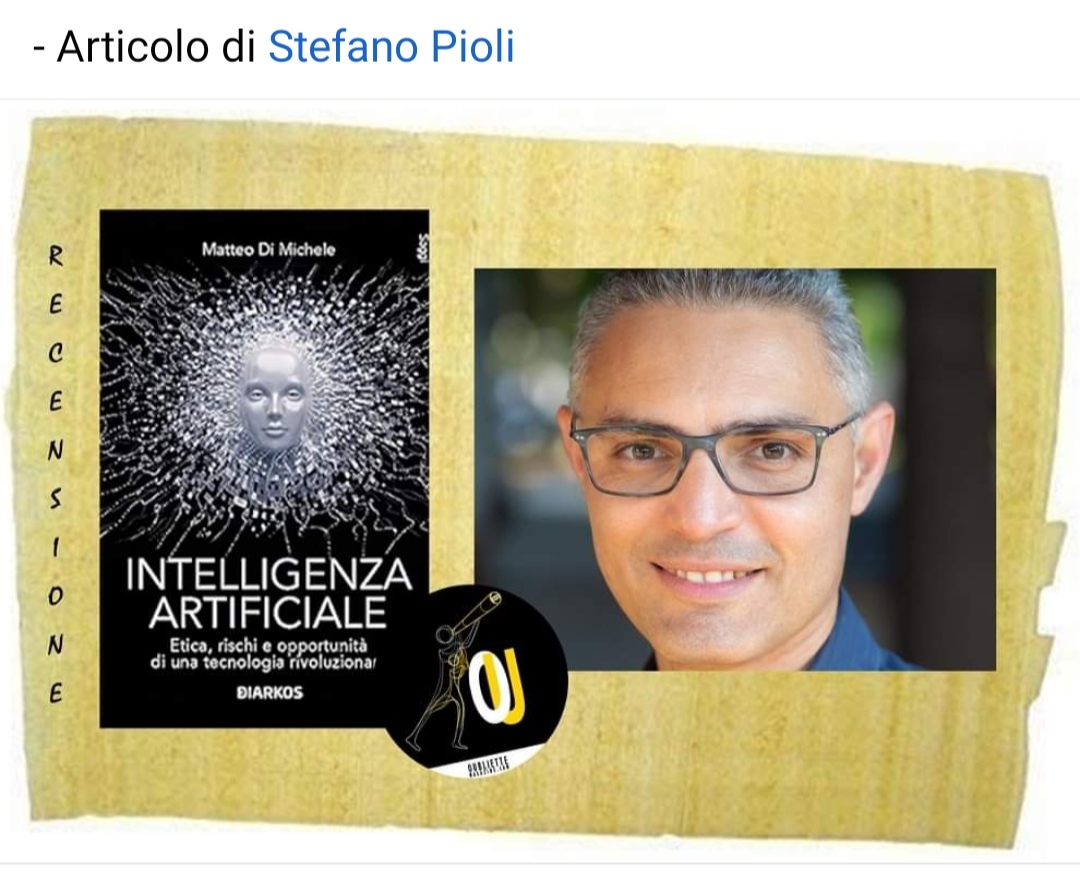
Intelligenza artificiale di Matteo Di Michele su Oubliette Magazine -Rischi ed implicazioni etiche dell’AI
19 Settembre 2023
È facile cogliere la lieve e quieta autoironia dell’autore. Cos’è un algoritmo? È una funzione che permette di giungere ad altre funzioni. È la prima mezza definizione che mi viene in mente. Meglio di me può, ovviamente, zio Google: una successione di istruzioni o passi che definiscono le operazioni da eseguire sui dati per ottenere i risultati. Sono cioè dei ready-made (realizzati da te o da altri) che ti consentono di implementare dei nuovi ragionamenti, che concretizzano al fine di. Ognuno ha poi il fine che si merita. Mi domando cosa potrebbe dire a proposito al-Khuwārizmī, salvifico matematico arabo del secolo IX, da cui deriva il termine. Mi chiedo anche se c, intesa come velocità della luce nel vuoto, sia anch’esso un algoritmo, di certo è un dato emerso da precedenti esperimenti che conduce ad altri risultati. A questo punto potrebbe esserlo ogni parola: un ready made che permette di velocizzare l’espressione di un ragionamento. Al fine di evitare descrizioni troppo lunghe del tipo Luciano Floridi, docente di qua (Bologna) e di là (Oxford e Yale), filosofo etico della comunicazione, sociologo della comunicazione, etc etc, io amo usare la sintetica e non se pure algoritmica formula: Prof (tutto maiuscolo).
Scrive Matteo Di Michele, a pagina 8 dell’Introduzione: “L’obiettivo di questo libro è di offrire ciò che manca oggi riguardo a questi temi: una panoramica completa dei rischi, delle opportunità e delle implicazioni etiche dell’ascesa delle macchine intelligenti, che organizzi in modo logico e metodico i differenti tipi di tecnologie e applicazioni.”: completa non sarà mai e di sicuro non se ne parlerà mai abbastanza.
Di recente ho letto due opere che tentano di dire qualcosa a proposito: Etica dell’intelligenza artificiale di Luciano Floridi; nonché 8 secondi della giornalista RAI Lisa Iotti che, tentano, con un certo successo, di interpretare alcuni aspetti della questione. I quali aspetti sono talmente tanti (pur ampiamente illustrati in questo saggio di Matteo Di Michele), che necessitano di sempre nuovi aggiornamenti e chiarimenti. Tanto per citare il re degli aforismi, Ennio Flaiano, che però si riferiva alla situazione politica, “la situazione è grave ma non è seria” ma, occorre aggiungere: sempre più complessa. En passant, lo scritto breve, epigrammatico, di cui lo studioso Gino Ruozzi è un inclìto cultore, è consanguineo dell’algoritmo, essendo entrambi figli della medesima intenzione: significare con il relativamente poco quel che vale il relativamente tanto e che al momento (e mai infine) ti condurrà altrove, in avanti, si spera.
Anche Mussolini fu creatore di tali pensieri icastici (del tipo Vincere! E vinceremo!), e non sempre la rapidità è segno di saggezza. La cauma è il calore soffocante, ma senza calore, senza calma, si rischia di far congelare il cervello. Occorre analizzare un fenomeno correlandosi alla sua velocità.
La Parte prima del presente saggio è L’ascesa delle macchine intelligenti.
“D’altra parte, è molto facile immaginare scenari in cui tali macchine non funzionino come previsto, sfuggano al controllo o finiscano nella mani sbagliate.” – il mio modo di interagire con un saggio è sempre foriero di rischi. Riporto e cito delle parti che estraggo arbitrariamente dal testo, seguendo quello che si definisce la usta, l’odore lasciato nell’ambiente dalla selvaggina. In Campania dicono i’ a uosémo, andare a naso. Intendo chiarire che il mio è un modo per interessare gli altri cacciatori/lettori a recarsi là dove ho raccolto alcune pietre preziose, quali sono le parole e le espressioni utilizzate dall’autore preso in esame. Se talvolta ex-agero, può capitare. Solo chi fa le cose, le può sbagliare.